Abbiamo detto che la creatività è un processo evolutivo caratterizzato da una fondamentale attitudine, ovvero dalla capacità di cambiamento in un modo che non sia determinabile a priori. Il concetto di evoluzione è trattato anche da R.N. Foster e S. Kaplan, due consulenti della McKinsey, i quali affermano che:
| "Le imprese debbono essere re-immaginate in modo da rafforzare la loro capacità di evolvere, invece della loro capacità di operare". |
Gli autori pensano che questo sia possibile solamente superando alcune dicotomie come ad esempio l'enfasi sulla discontinuità da un lato e sulla continuità dall'altro lato, il contrasto tra creare e operare, ma anche tra divergenza e convergenza e infine tra controllo e libertà di azione e di rischio.
Fig. 5.1 - Creatività organizzativa
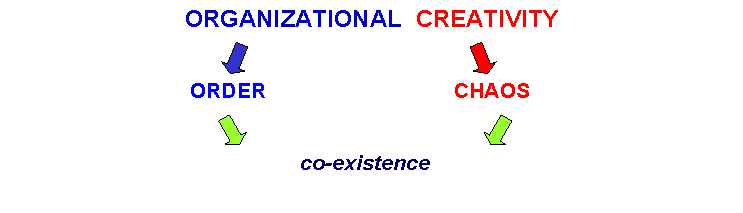
Continuità vs discontinuità
A proposito della prima dicotomia, quella tra continuità e discontinuità, si può affermare che generalmente le imprese sono pianificate e costruite sul principio della continuità. Questo significa che le organizzazioni non sono capaci di innovare allo stesso ritmo del mercato, dato che esse sono focalizzate sui loro processi operativi. Il problema è che non possono creare un ambiente organizzativo in grado di favorire lo sviluppo di nuove idee e la rapida eliminazione di quelle più vecchie. Questo è dovuto al fatto che le imprese sono soggette a blocchi culturali, che portano a commettere errori di pianificazione strategica e che inducono ad attuare routines difensive che determinano una minore capacità di innovazione. Tuttavia la realtà del mercato è piuttosto differente. I mercati funzionano basandosi sull'assunto della discontinuità e ciò significa che essi possono creare maggiore sorpresa e innovazione rispetto alle imprese. Questo è dovuto al fatto che essi non hanno sistemi di controllo, non hanno cultura, non hanno modelli mentali che possano indurre una qualche routine difensiva. I mercati non hanno rimpianti; essi eliminano gli operatori più deboli e, agendo in questo modo, aumentano i ritorni globali.
Fig. 5.2 - Continuità vs discontinuità
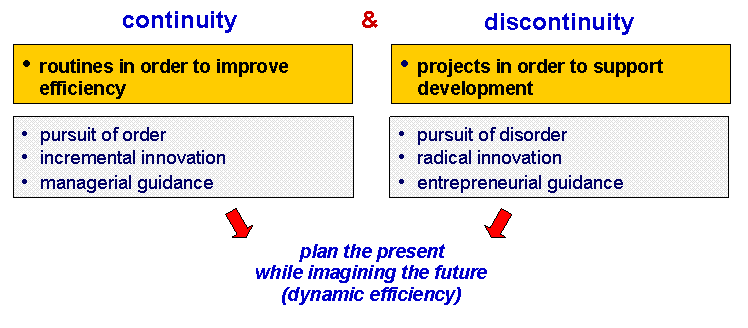
Operare vs creare
Per poter accettare il principio di discontinuità le organizzazioni devono spostare l'attenzione dall'eccellenza operativa alla creazione ed innovazione. Infatti l'eccellenza operativa non è sufficiente per evolvere allo stesso ritmo e intensità del mercato. Quindi è necessario adottare un altro approccio. Il management tradizionale si focalizza sull'analisi e controllo, su un alto livello di efficienza produttiva, sulle competenze logistiche e commerciali, su una buona capacità esecutiva.
Fig. 5.3 - Operare vs creare
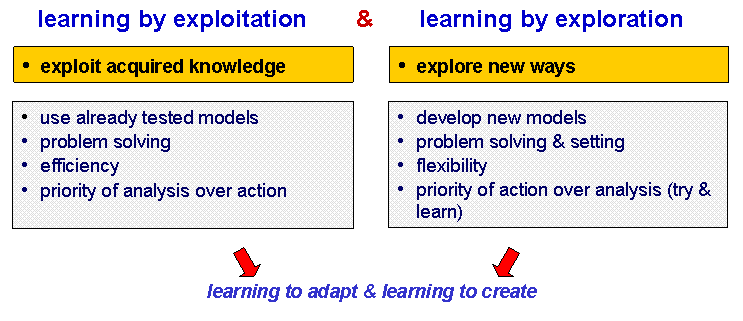
Convergenza vs divergenza
Le imprese che vogliono utilizzare questo tipo di approccio devono incrementare la varietà dei loro modelli mentali perché i mercati non sono caratterizzati da grande uniformità di pensiero. In particolare, questo fatto richiede la capacità di usare sia il pensiero convergente che divergente.
L'obiettivo del pensiero divergente è quello di modificare la definizione di un problema o il contesto dove dovrebbe essere risolta. Ciò significa avere una varietà di prospettive, facendo associazioni inusuali, realizzando quella che Koestler [1] definisce "fertilizzazione incrociata", che significa, per esempio, mettere in contatto persone con diverse esperienze appartenenti a differenti culture.
Inoltre il pensiero divergente è composto da tre diverse fasi, che sono: la ricerca del problema (perché il processo creativo inizia dalla percezione di un problema o di un compito da realizzare); l'incubazione durante la quale le persone devono sospendere i loro giudizi in modo da accrescere la possibilità di pervenire a una visione originale del problema; quindi possiamo dire che l'incubazione è esattamente l'opposto del normale processo di business che si svolge in una organizzazione operativa. Infine si ha la collisione, che significa creare una nuova idea collegando diverse informazioni e prospettive.
Queste tre fasi definiscono il processo di pensiero divergente, che è la fonte del processo creativo; ma il problema è che queste competenze non vengono mai sviluppate dalle organizzazioni, che sono invece generalmente focalizzate sul pensiero convergente.
Potremmo dire che il pensiero convergente è la seconda fase del processo creativo. Questo tipo di pensiero è fondamentale per l'attività analitica ed è misurabile attraverso un test per il quoziente intellettivo. Si riferisce a problemi razionali e ben definiti, che hanno una sola risposta corretta. Questo è un tipo di pensiero analitico, che si focalizza sui dettagli essenziali, che seleziona le idee secondo la loro importanza e semplifica i problemi considerando solo i dettagli più importanti. Le organizzazioni generalmente applicano il pensiero convergente a problemi operativi, ma l'atto della creazione è piuttosto differente rispetto a questo tipo di problemi. I processi creativi richiedono da un lato alcune attività divergenti come la ricerca (cioè l'osservazione), l'incubazione (riflessione) e la collisione (che può partire dalla conversazione). Dall'altro lato si hanno delle attività convergenti come prendere delle decisioni e sperimentarle (testarle).
Fig. 5.4 - Convergenza vs divergenza
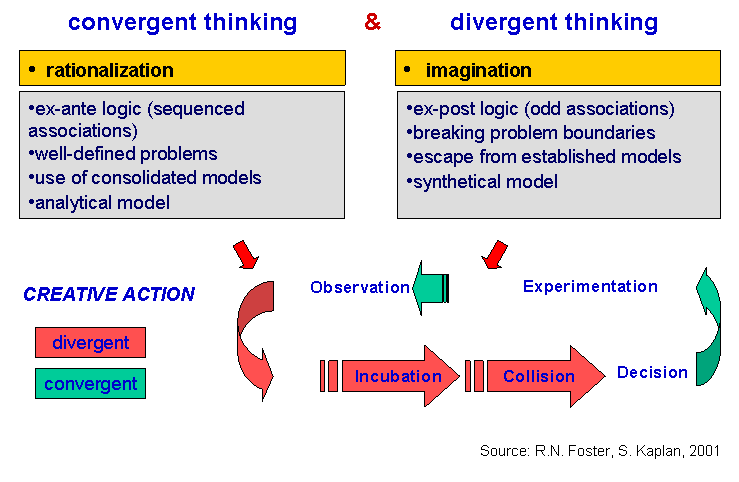
Controllo vs libertà di azione e rischio
Il problema è che controllare la creatività richiede un cambiamento di persone e contesto, ciò equivale a dire bilanciare discontinuità e continuità, divergenza e convergenza e infine controllo e libertà di azione. Infatti ciò che rende il processo creativo qualcosa di veramente difficile per le imprese è dare agli impiegati la possibilità di sviluppare le loro idee e commettere di conseguenza degli errori. Quindi, da un lato si ha il management tradizionale che usa il controllo in modo da eliminare sorprese, creare un ambiente di lavoro stabile ed evitare di prendere rischi eccessivi, mentre dall'altro vi è la necessità di favorire uno spirito imprenditoriale, che richieda una certa libertà di azione, cioè la possibilità di tradurre le idee di ciascuno in qualcosa di pratico e di commettere anche degli errori.
Fig. 5.5 - Controllo vs libertà di azione e rischio
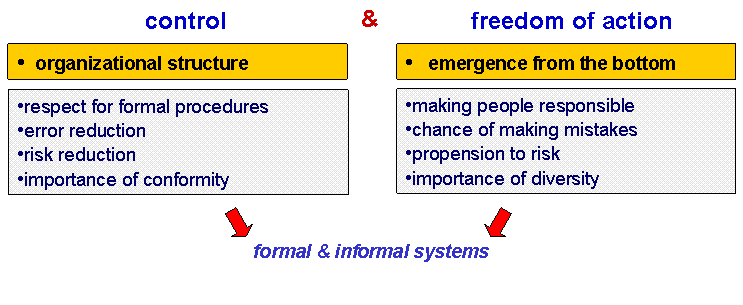
[1] A. Koestler, L'atto della creazione, Roma, Astrolabio-Ubaldini, 1975.
| <-- PAG.PRECEDENTE | TORNA SU | INDICE | PAG.SUCCESSIVA --> |