La ricerca sul tema della creatività all'interno delle imprese, che l'Università di Udine sta portando avanti, trae origine dagli studi sulla teoria della complessità. Infatti abbiamo scoperto che la creatività è un fenomeno complesso e ne abbiamo compreso l'importanza per gli animali, per gli esseri umani e per le imprese. La teoria della complessità studia i sistemi adattativi complessi: che cosa sono?
SISTEMI ADATTATIVI COMPLESSI (CAS)
La teoria della complessità è una scienza multidisciplinare (Morin, 1990; De Angelis, 1996; Battramm, 1999): essa prende in considerazione elementi di discipline molto diverse tra loro, quali ad esempio la teoria dei sistemi, la cibernetica, la metodologia, la teoria del caos, l'intelligenza artificiale (A.I.), la vita artificiale, le scienze cognitive, l'informatica, l'ecologia, l'economia, gli studi sull'evoluzione, la genetica, la teoria dei giochi, l'immunologia, la linguistica, la filosofia, le scienze sociali, il management (fig. 1).
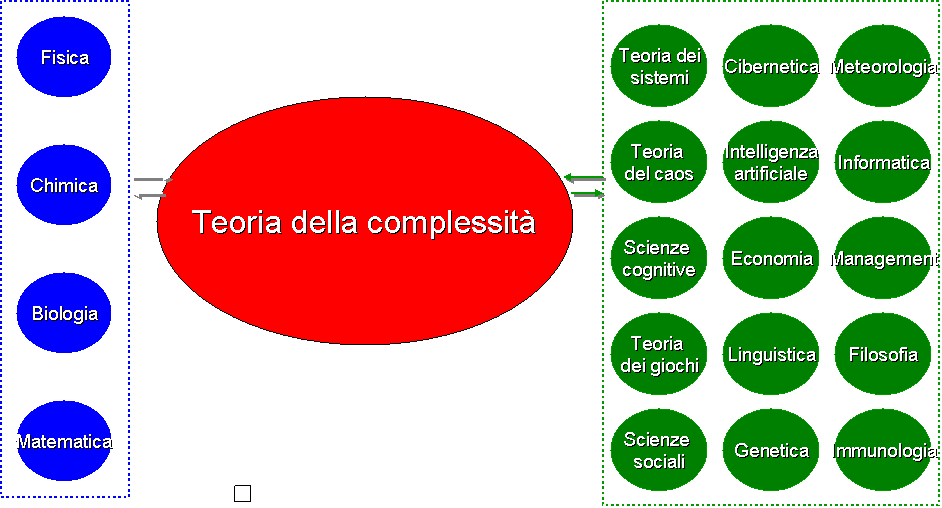
Fig. 1 - La teoria della complessità come scienza multidisciplinare.
I sistemi complessi sono caratterizzati da elementi numerosi e differenti e da connessioni numerose e non-lineari; inoltre i CAS, che sono sistemi complessi viventi, sono caratterizzati dalla capacità di adattamento (Holland, 2002). Un CAS può quindi essere descritto come un insieme di agenti e di connessioni, organizzato in modo da permettere l'adattamento: secondo quanto affermato da Holland (1995) un CAS è un sistema che emerge al di là del tempo in modo coerente e adatta e organizza se stesso senza che una particolare entità lo gestisca o lo controlli deliberatamente.
Questa capacità di adattamento è ottenuta attraverso l'elaborazione delle informazioni e la costruzione di un modello (Cerrato, 1996): l'obiettivo più importante per gli elementi di un sistema è l'adattamento e per ottenere il loro obiettivo essi cercano continuamente nuovi modi per fare le cose e di apprendere. Quindi, essi creano dei sistemi estremamente dinamici, dove piccoli cambiamenti possono causare conseguenze inimmaginabili (Axelrod e Cohen, 1999), cioè, "l'effetto farfalla". Essi si pongono tra la semplicità - troppo vicina all'immobilità di un meccanismo - e l'imprevedibilità - troppo vicina alla perdita di controllo (Battram, 1999).
PRINCIPI DELLA TEORIA DELLA COMPLESSITA' E PROGETTO CREATE
Dal momento che la teoria della complessità è una scienza multidisciplinare, i contributi in letteratura sono numerosi ed eterogenei. Ciò nonostante, abbiamo cercato di razionalizzare questo vasto campo di ricerca identificando sette principi della teoria della complessità e sette principi conseguenti per le imprese (fig. 2, fonte: De Toni e Comello, 2004), che possono essere considerate anch'esse sistemi adattativi complessi.

Fig. 2 - Principi della teoria e gestione della complessità (De Toni and Comello, 2004).
Per il progetto CREATE ci siamo concentrati sull'importante principio della complessità relativo alla disorganizzazione creativa. A partire da esso, abbiamo cercato di trovare le più importanti tecniche che possano accrescere la creatività all'interno delle imprese (fig. 3).
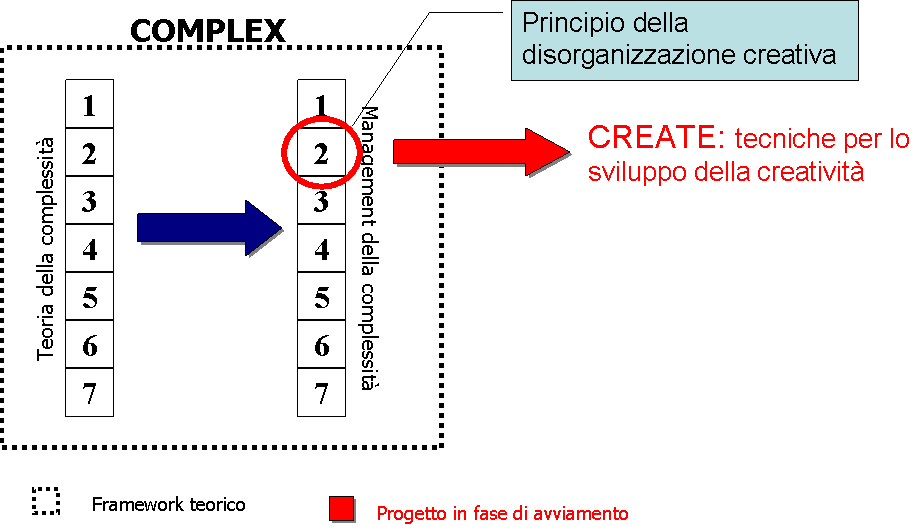
Fig. 3 - Dai principi della teoria della complessità al progetto CREATE.
L'ORLO DEL CAOS
Il principio della teoria della complessità che sottolinea l'importanza della creatività per ogni sistema adattativo complesso è quello definito "orlo del caos". L'evoluzione porta i CAS nell'area tra ordine e disordine chiamata dagli studiosi di complessità "orlo del caos" (Waldrop, 1992). Esso è l'unico posto nel quale la vita può prendere piede. Troppo ordine causa morte per fossilizzazione, troppo disordine causa morte per disintegrazione. Secondo Cohen (1997, p.69): "All'orlo del caos, i confini del cambiamento ondeggiano continuamente tra uno stato di stagnazione e l'anarchia della distruzione senza fine". Quindi, l'orlo del caos è una zona pericolosa da visitare. Non è né ordine né disordine. E' luogo di creazione, ma può essere anche luogo di distruzione.
Questo principio ci invita ad accettare la contemporanea presenza di concetti contrastanti (Marzo, 1990), come ad esempio ordine e disordine, creazione e distruzione, vita e morte. Dovremmo spostarci dalla cultura dell' "OR" alla cultura dell' "AND" (Amietta, 1991): le cose non si escutono da sole, non si annullano l'un l'altra, non si neutralizzano, ma coesistono, si sommano tra loro, si integrano, si richiamano, trovano tra di loro un equilibrio dinamico. Inoltre bisogna accettare il disordine come un qualcosa di necessario alla creazione (Morin, 1990). Il disordine è ovunque (Bohm, 1957): nei sistemi viventi (Morin, 1990), nella nostra mente (De Angelis, 1996), in ogni organizzazione (Quattrocchi, 1984), nella storia (Waldrop, 1992).
LA DISORGANIZZAZIONE CREATIVA
Le imprese possono ottenere l'orlo del caos attraverso la disorganizzazione creativa, un principio simile al concetto di innovazione proposto dall'economista austriaco Schumpeter (1942), il quale definisce "gli agglomerati dell'esplosione" che genera un cambiamento come "una tempesta perpetua di distruzione creatrice". Nei CAS, e allo stesso modo nelle organizzazioni, dove gli agenti sono dotati di un elevato grado di autonomia in modo da essere in grado di prendere decisioni a livello locale, i risultati possono emergere secondo un sistema di deviazione-amplificazione o attraverso dei feedback positivi (Doodley and Van de Ven, 1999). Molte attività creative che si ritrovano nelle imprese emergono in questo modo. Quindi, è necessario abbandonare l'idea che il successo provenga dalla stabilità e dall'ordine: vita e innovazione sono generate all'orlo del caos (fig. 4) - tra strutture formali ed informali (Pascale, 1990; Stacey, 1991, 1992). Dee Hock, uno dei soci fondatori di VISA, chiama la sua organizzazione "chaord organization", dove chaord sta ad indicare il giusto mix tra caos e ordine (Savane, 1996).

Fig. 4 - L'orlo del caos tra ordine e disordine (De Toni and Comello, 2004).
La disorganizzazione creativa può essere favorita agendo secondo tre direzioni differenti: strutture organizzative, stili direzionali e management.
Riguardo alle strutture organizzative, è necessario creare una struttura piatta (Peters, 1992; Savane, 1996), coordinamento laterale (Foster e Kaplan, 2001) e decentralizzazione delle decisioni (Pascale, 1992; Peters, 1992).
Riguardo agli stili direzionali, è necessario sviluppare imprenditorialità (Peters, 1992; Keene, 2000), non avere paura degli errori (Pascale, 1992; Peters, 1992; Foster e Kaplan, 2001) e non temere i conflitti ma sfruttarli (Pascale, 1992; Ciappei e Poggi, 1997; Olson e Eoyang, 2001).
Riguardo al management, è importante usare tecniche per sviluppare la creatività individuale e di gruppo (Peters, 1992; Foster e Kaplan, 2001).
Le capacità necessarie al processo innovativo sono individuabili nei suppliers ed emergono come conseguenza delle interazioni tra due parti. In tal senso, c'è la necessità di adottare tecniche creative per lo sviluppo di prodotti in modo collaborativo. In particolare nel progetto CREATE abbiamo proposto una metodologia che si articola in cinque fasi per la far nascere collaborazione e nuove idee: mappatura interna ed esterna, predisposizione, processo creativo vero e proprio e valutazione (fig. 5).
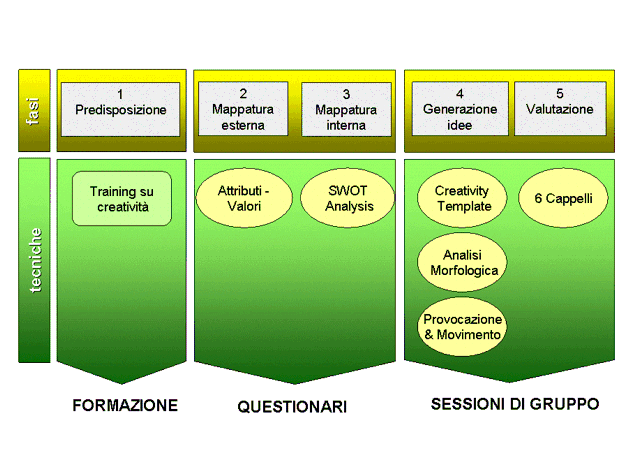
Fig. 5 - Fasi e tecniche per il potenziamento della creatività nelle imprese (De Toni, Sanfilippo and Comello, 2004).
La predisposizione si riferisce alla creazione dell'ambiente interno che possa favorire nuove idee e contribuisca ad eliminare rapidamente quelle obsolete. Noi pensiamo che un training creativo preliminare possa essere particolarmente utile per mettere le persone a proprio agio nella discussione, in modo particolare sfruttando alcune tecniche e procedure di base.
Riguardo la mappatura esterna, le imprese percepiscono gli stimoli provenienti dall'esterno e li interpretano secondo la loro conoscenza. Per raccogliere i segnali esterni è essenziale che le organizzazioni partecipino a fiere e meetings, che siano in contatto con i suppliers e che sviluppino idee interessanti riguardo la relazione tra esse e l'impresa stessa. Una tecnica importante è l'analisi attributi-valori.
La mappatura interna riguarda invece la valutazione del capitale cognitivo interno all'organizzazione in modo da sfruttare il suo potenziale e lasciare che nuove idee possano emergere. Una tecnica che può essere utilizzata per la mappatura interna è la SWOT analysis. Questa tecnica può essere utilizzata sia per identificare problemi interni non ancora evidenti, sia per porre attenzione su nuovi elementi.
Il processo creativo è la generazione di idee. In questa fase può essere utile coinvolgere i suppliers in modo da realizzare una sorta di "fertilizzazione incrociata" (Koestler, 1975) e generare nuove idee.
La valutazione consiste nella selezione delle migliori idee nel rispetto del criterio di giudizio interno dell'impresa. La tecnica che noi suggeriamo per questa fase sono i sei cappelli per pensare di E. De Bono (1002). Essa permette di dividere la logica dalle emozioni, la creatività dalle informazioni, la generazione di idee dalla loro valutazione e di considerare le idee da diversi punti di vista.